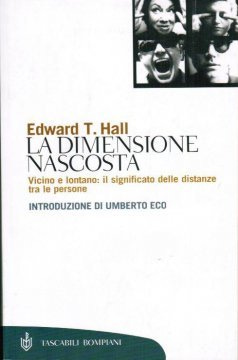#42/2023 - La prossemica
Psicologia & Comunicazione
Se dovessimo definirla in una sola frase, potremmo dire che la prossemica è la scienza che studia le distanze interpersonali.
In effetti il distanziamento che le persone adottano nei rapporti sociali è uno degli aspetti meno noti ma anche più rilevanti della comunicazione non verbale. Ecco perché oggi impariamo a conoscerla e riconoscerla, riferendoci soprattutto alle ricerche condotte dal principale esponente di questa disciplina.
Etimologia e significato di prossemica 📖
Cominciamo a conoscere la prossemica partendo dall’etimologia. Il termine inglese proxemics viene introdotto dall’antropologo Edward T. Hall e deriva da proximity, ovvero prossimità.
L’origine del termine ci aiuta già molto a comprendere l’importanza e il significato dello spazio in ambito sociale e comunicativo. La prossemica riguarda proprio lo studio della comunicazione non verbale attraverso l'analisi dello spazio e della distanza, nonché del contatto fisico e del movimento all'interno di una conversazione o di un contesto interpersonale.
Tutti questi aspetti non possono essere ignorati se si intende davvero comprendere i messaggi dei nostri interlocutori. Ti è mai capitato di notare un approccio contrastante tra linguaggio del corpo e discorso? Magari qualcuno che diceva felice di essere lì con te ma se ne stava rivolto in un’altra direzione con le braccia incrociate?
Ecco, conoscere la prossemica, come vedremo, è di grande aiuto nella comprensione delle relazioni sociali.
Le 4 distanze interpersonali ↔️
Soffermiamoci sulla questione spazio-distanza e torniamo per un momento al padre della prossemica, Edward T. Hall.
Fu proprio lui, nel 1968, a compiere una serie di studi sulla base dell’osservazione delle interazioni umane. Hall arrivò a teorizzare 4 distanze interpersonali che differiscono in base al tipo di relazione sociale tra gli interlocutori. Vediamole:
1️⃣ Distanza intima (0 - 45 cm)
Come è facile comprendere, questa distanza è riservata alle relazioni più intime. È lo spazio ristretto che consente un contatto fisico stretto, sussurri e in generale atteggiamenti che servono a rafforzare un legame di confidenza e fiducia.
All’interno della distanza intima, possiamo individuare la zona intima ristretta (0-15 cm), dedicata ai contatti fisici più intimi e riservati.
2️⃣ Distanza personale (45 - 120 cm)
Dedicata alle interazioni con amici e persone che ci sono familiari. Possiamo affermare con tranquillità che si tratta della distanza più utilizzata durante la maggior parte delle interazioni sociali, come feste, eventi etc.
Questo perché si tratta della distanza più “neutra” per comunicare con persone che conosciamo ma con le quali non siamo in rapporti intimi.
3️⃣ Distanza sociale (120 - 300 cm)
È la distanza degli incontri formali. In generale, è lo spazio riservato agli incontri professionali o alle persone appena conosciute. Si tratta di una scelta che esprime rispetto verso lo spazio personale dell’altra persona, dunque consente di interagire senza risultare eccessivamente invadenti.
È interessante notare quanto abbiamo usufruito di questa distanza durante la pandemia; il “distanziamento sociale” di almeno 1 metro è stato il nostro riferimento per la lotta al Covid, da applicare anche in contesti in cui la distanza che avremmo adottato naturalmente era quella personale o quella intima.
4️⃣ Distanza pubblica (oltre 3 metri)
Si tratta dello spazio che interponiamo tra noi e gli sconosciuti. Utilizzata tipicamente nei contesti pubblici come conferenze, discorsi o eventi di massa.
Violare le regole della prossemica 🙅🏻
Abbiamo visto quanto la prossemica segua uno schema ben preciso. Si tratta, infatti, di un comportamento che pensiamo di adottare in maniera priva di senso e disinvolta ma che, in realtà, è ampiamente influenzato dalle regole sociali e, vedremo, persino dalla cultura di riferimento.
Ma cosa accade, dunque, in quelle occasioni in cui non è possibile rispettare lo schema della prossemica? Pensiamo a situazioni di tutti i giorni in cui ci troviamo costretti a infrangere queste regole spaziali e, in qualche modo, a violare lo spazio altrui.
In ascensore 🛗
Una situazione piuttosto frequente in cui siamo a contatto ravvicinato con gli estranei è l’ascensore. Vi è di solito un certo disagio, riscontrabile nel fatto che si tende a disporsi o attaccati agli angoli, vicini alle pareti o, come spesso accade nei film americani, tutti rivolti verso la stessa direzione, con le spalle parallele alla parete posteriore.
Insomma, il fulcro sembra essere proprio evitare il contatto visivo. Come mai? La risposta è da rintracciare proprio nel grande silente valore della prossemica: il nostro spazio fisico e mentale è infatti fondamentale per mantenerci a nostro agio nelle interazioni con gli altri.

Sui mezzi pubblici 🚌
Un’altra situazione comune in cui siamo spesso costretti a proteggere la nostra bolla prossemica è quando ci troviamo sui mezzi pubblici.
Prova questo esperimento: la prossima volta che prenderai l’autobus, la metropolitana o qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, osserva come le persone utilizzano il proprio corpo e il proprio spazio per comunicare.
Noterai che c’è chi tende a sedersi a gambe aperte, occupando molto spazio e, spesso, invadendo lo spazio di chi gli sta accanto; altri sono più rannicchiati, in una situazione di evidente maggiore disagio.
Quando qualcuno si avvicina troppo a noi, infatti, possiamo avvertire una sensazione spiacevole, come se ci sentissimo invasi. È in queste situazioni che tendiamo, per esempio, a evitare il contatto visivo (pensiamo al già citato caso dell’ascensore).
Questo perché anche guardare qualcuno negli occhi è spesso interpretato come un gesto intimo (in alcuni casi anche intimidatorio); dunque, evitare il contatto visivo è spesso l’unico strumento per proteggere la nostra intimità in situazioni di vicinanza fisica.
La prossemica non è universale 🌍
Fino ad ora, abbiamo parlato della prossemica in modo piuttosto granitico. Non abbiamo tenuto in considerazione le variabili dettate da cultura, contesto e intenzioni. Partiamo dalla più rilevante: la cultura.
Paese che vai, prossemica che trovi 🗺️
È importante tenere presente che le indicazioni comuni sulla prossemica subiscono l’influenza della cultura di riferimento: ciò che potrebbe essere considerato un comportamento normale in una cultura potrebbe essere percepito come invadente in un’altra.
Ad esempio, nelle culture orientali, le distanze personali sono spesso più marcate rispetto alle culture occidentali, il che può portare a malintesi o a percezioni errate nelle interazioni interculturali.
Sempre a questo proposito, lo studioso Hall ha classificato le differenze culturali in due grandi insiemi:
le culture di contatto
le culture senza contatto.
Le prime, che comprendono paesi arabi, francesi, italiani e latino-americani, possiedono un’alta propensione al contatto fisico per comunicare, mentre le seconde mancano di questa inclinazione.
Nelle culture senza contatto troviamo i paesi nordeuropei, nordamericani e asiatici.
Pensiamo a noi italiani, una cultura collettivista: siamo abituati a stare molto vicini, a scambiarci abbracci e baci sulle guance; insomma, siamo decisamente propensi al contatto fisico. Questo modo di porsi può essere visto come invadente o poco rispettoso da persone che condividono una cultura dove la distanza interpersonale è più ampia e molto importante.
Ecco perché la gestualità, il contatto fisico e addirittura il tono della voce devono essere modulati tenendo conto delle differenti culture di riferimento.
In Giappone, ad esempio, le coppie tendono a essere molto più schive e composte di quanto potremmo immaginare: in vista di un futuro viaggio a Tokyo con la dolce metà, per mantenere un comportamento rispettoso del luogo che visiti ricorda di evitare le effusioni in pubblico!
Prossemica e contesto comunicativo 🗣️
Anche il contesto e l’intento comunicativo sono rilevanti: quando siamo arrabbiati, tendiamo ad annullare la distanza tra noi e gli altri, per tentare di prevaricare l’altro. Anche il contatto visivo, in questo caso, assume la connotazione di sfida e aggressività.
Pensiamo poi alla maggiore compostezza riservata al posto di lavoro: anche tra colleghi, infatti, tendiamo a mantenere una distanza maggiore rispetto a quanto facciamo fuori dall’orario lavorativo.
Conclusioni 💭
Studiare la prossemica - o quantomeno sapere che esiste - ci aiuta a comprendere meglio il linguaggio non verbale e a interpretare correttamente i messaggi che gli altri stanno trasmettendo, rendendo così la nostra comunicazione più ricca e accurata.
È innegabile: il corpo parla anche quando stiamo zitti…e svela più di quanto immaginiamo!
Se vuoi approfondire questa affascinante scienza, non perderti “La Dimensione nascosta”, il testo del 1966 di Hall che, nella traduzione italiana, contiene una prefazione di Umberto Eco.
Hall schematizza le differenze culturali attraverso casi pratici curiosi e divertenti.
Il libro è più attuale di quanto si immagini, a dimostrazione che la prossemica è una scienza solida e non una moda passeggera.