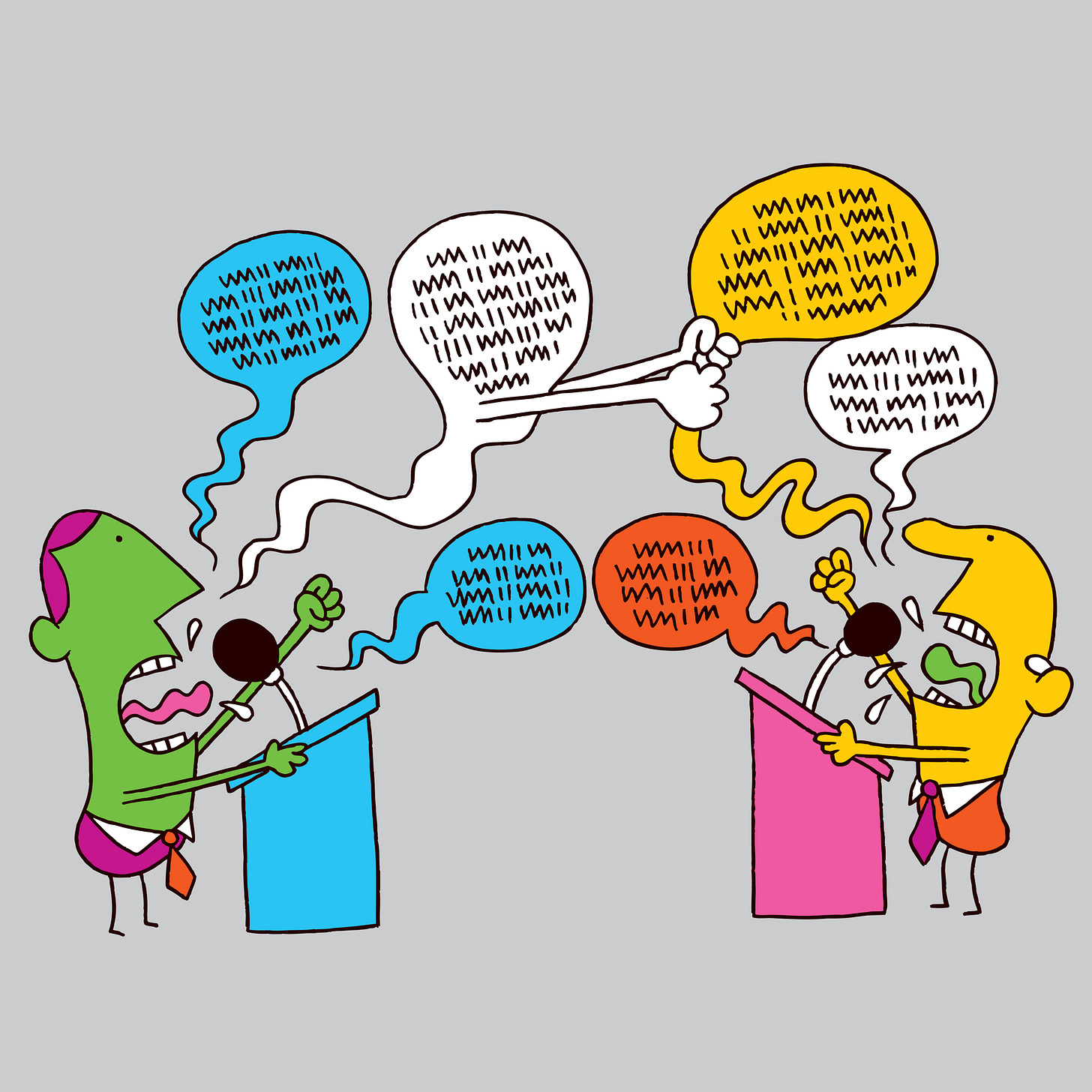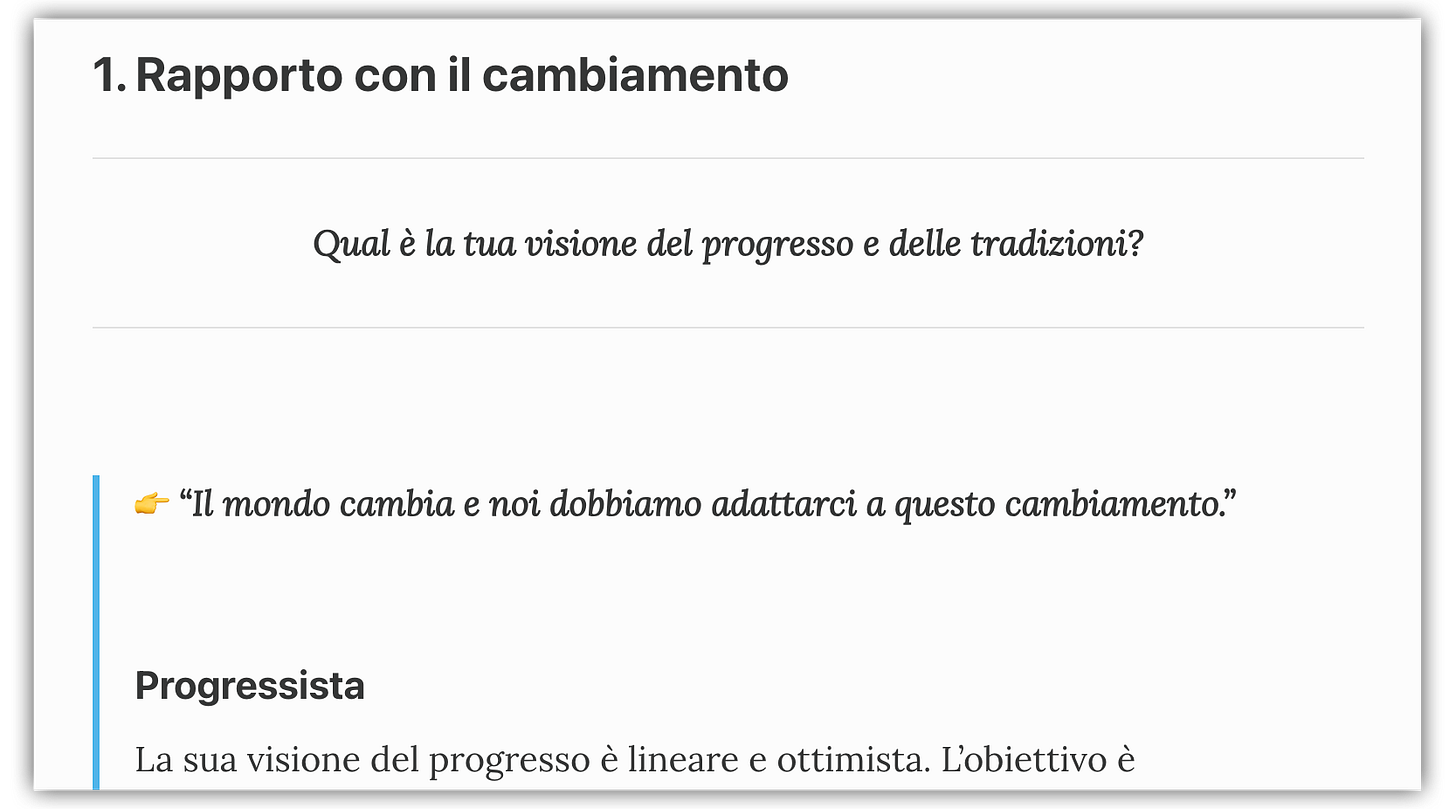Destra e sinistra (10+1 curiosità)
La tua dose settimanale di cultura generale! || Edizione del 141° giovedì || 5 min. di lettura
Benvenuto! Oggi affrontiamo un tema scivoloso, spesso ridotto a tifo da stadio: la divisione tra destra e sinistra. Ma da dove arriva? E, soprattutto, ha ancora senso?
Partiamo dall’inizio. Come in ogni buona storia, tutto comincia con…delle persone che scelgono da che parte sedersi.
🍷 Che storia!
L’aneddoto della settimana.
Da dove arrivano “destra” e “sinistra”?
L’origine delle categorie politiche di destra, sinistra e centro risale alla Rivoluzione Francese. Nel maggio del 1789, durante la riunione degli Stati Generali, i rappresentanti del Terzo Stato (membri della borghesia e del popolo, non parte di clero e nobiltà) si divisero simbolicamente all’interno dell’aula.
Alla destra del presidente, si accomodarono i sostenitori dell’ordine esistente, della monarchia e dei privilegi tradizionali. Alla sinistra del presidente, presero posto i rivoluzionari, quelli che spingono per un cambiamento radicale, per i diritti del popolo e per una rottura netta con il passato.
Lo spazio centrale venne presto etichettato in modo polemico come “la palude”, perché considerato privo di una posizione chiara e ben definita.
Con la restaurazione del XIX secolo, questa disposizione si consolidò: a destra sedevano i difensori dell’ancien régime, a sinistra coloro che spingevano per portare avanti i principi democratici della Rivoluzione.
E il centro?
Quella che durante la Rivoluzione Francese veniva chiamata in tono dispregiativo “palude”, con il tempo si è nobilitata, diventando il centro: non più un simbolo di indecisione, ma la ricerca di equilibrio tra gli estremi.
Morale: “destra/sinistra/centro” non sono etichette eterne. Sono coordinate pratiche nate da dove ti siedi quando devi decidere, e cambiano con i problemi del tempo.
⚡️ Pillole 10 x 10 → Destra e sinistra
Dieci curiosità da dieci secondi. Per conoscere, stupirsi, riflettere.
Padre severo vs. genitore premuroso. Secondo il linguista cognitivo George Lakoff, la politica si fonda su due metafore inconsce della famiglia. La destra usa il modello del “padre severo”: disciplina, auto-sufficienza, punizione per chi sbaglia. La sinistra quello del “genitore premuroso”: empatia, cura, supporto per chi è in difficoltà. Due visioni morali opposte su come lo “Stato-famiglia” dovrebbe essere governato.
Dimmi quanti vicini hai e ti dirò cosa voti. Oggi, il singolo dato più predittivo del voto in Occidente non è il reddito, ma la densità abitativa. Le metropoli multiculturali e individualiste votano a sinistra. Le province, omogenee e comunitarie votano a destra.
Il significato dei colori. In Europa, il rosso è da sempre il colore della sinistra, legato alle rivoluzioni operaie e alla bandiera della Comune di Parigi del 1871. Negli Stati Uniti è l’opposto: il rosso è il colore del partito Repubblicano (destra), mentre il blu è quello dei Democratici, per una convenzione televisiva nata durante le elezioni del 2000, quando le emittenti TV usarono questi colori per le mappe elettorali e finirono per fissarli nell’immaginario collettivo.
Cervello e politica. Diversi studi, riassunti nel lavoro dello psicologo sociale Jonathan Haidt, mostrano che il nostro “cervello politico” è dotato di sistemi di allerta differenti. I conservatori possiedono un radar più sensibile per le minacce: il disordine, la rottura della tradizione, il tradimento del gruppo. I progressisti, invece, hanno un radar più sintonizzato sull’ingiustizia: la sofferenza degli oppressi, l’abuso di potere, la disuguaglianza. Non si tratta di una reazione “giusta” e una “sbagliata”, ma di due meccanismi di sopravvivenza evolutivi.
La destra e sinistra “nostrane” non sono uguali a quelle estere. Un “democratico” americano è considerato “di sinistra” negli USA. Ma nel dibattito europeo, le sue idee su sanità, scuola pubblica e intervento statale lo posizionerebbero molto più al centro. Un francese di destra difende la laicità dello stato con maggiore enfasi di un italiano di destra. Un indiano di destra promuove imponenti programmi di welfare statale che, decontestualizzati, potrebbero apparire “di sinistra” a un osservatore occidentale. Morale: l’asse destra/sinistra non è un righello universale, dipende sempre dal contesto locale.
L’universalismo e le sue tribù: il dilemma della sinistra. La sinistra moderna vive una profonda tensione interna che spiega molte delle sue contraddizioni. Da un lato, l’eredità illuminista la spinge a difendere i diritti universali (“siamo tutti uguali”). Dall’altro, l’influenza post-moderna la porta a discernere e valorizzare le identità di gruppo (femminismo, movimenti etnici e di genere). Tenere insieme le due cose è la sfida teorica della sinistra contemporanea.
L’ordine è il contrario della libertà? Il dilemma della destra. Per la destra, libertà e ordine sono due concetti che risuonano, ma accostandoli sembra di parlare del giorno e della notte. In realtà, l’ordine è la pre-condizione fragile e indispensabile per qualsiasi libertà. Senza un ordine garantito dalla legge, non c’è mercato, non c’è proprietà, non c’è sicurezza: c’è solo la legge di chi fa il prepotente.
Il primo sistema di welfare moderno fu introdotto da un cancelliere conservatore. Otto von Bismarck, nella Germania del 1880, varò i primi sistemi obbligatori di assicurazione malattia, infortuni, vecchiaia, per disinnescare il fascino del socialismo in crescita tra la classe operaia. Le politiche nascono anche dal puro calcolo strategico.
Perché negli USA ci sono solo due partiti? Colpa del sistema elettorale maggioritario secco (”winner-takes-all”): in ogni collegio, chi prende un voto in più vince tutto, e gli altri zero. Questa logica rende quasi impossibile la sopravvivenza di un terzo partito, costringendo ogni nuova idea a confluire in uno dei due schieramenti esistenti: repubblicano o democratico.
La teoria del ferro di cavallo. Immagina lo spettro politico non come una linea retta, ma come un ferro di cavallo. Man mano che ci si allontana dal centro, le posizioni di estrema destra e di estrema sinistra iniziano ad avvicinarsi. Autoritarismo, culto del leader, avversione per il liberalismo e uso della violenza diventano tratti comuni.
🚀 Passa al livello superiore
Cultura generale a 360°.
Glossario delle correnti politiche → Lunedì prossimo su Cultura 360.
Impara il significato profondo dei termini che leggi nei giornali. Se le etichette di “destra” e “sinistra” ti sembrano strette o imprecise, è perché lo sono. Sono contenitori. La vera domanda non è se sei di destra o di sinistra, ma in cosa credi.
Chi vive di politica o giornalismo dà per scontato il significato di parole come progressista, conservatore, reazionario, socialdemocratico, etc. Per tutti gli altri, le riassumiamo in un nuovo glossario ragionato, diviso per 4 aree tematiche.
Iscriviti a 💎 Cultura 360 e ricevi la mappa per dare i nomi giusti alle tue idee (così smetti di litigare sui termini e inizi a discutere i concetti).
A giovedì prossimo, con nuove curiosità in formato tascabile.
Giovanbattista & lo staff di Cultura Aumentata
È la curiosità che mi fa svegliare alla mattina.
— Federico Fellini