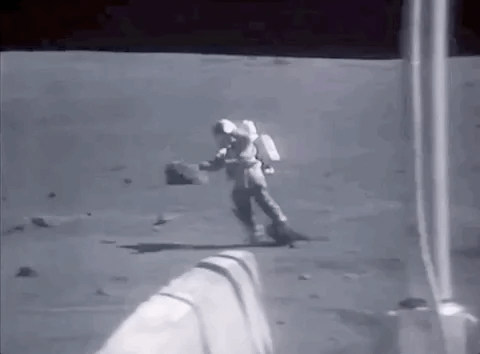Quanto peseresti su un altro pianeta? (E altre curiosità di cultura generale)
Cultura Aumentata - Newsletter n° 94 - Tempo di lettura: 5 minuti
⚡️ 1 ⚡️
- Un fatto strano ma vero -
💡 A Figeac, in Francia, c’è una piazza su cui è stata riprodotta una copia gigante della Stele di Rosetta. (Figeac è la città natale di Jean François Champollion, l’archeologo che per primo decifrò la lingua geroglifica egizia).
⚡️ 2 ⚡️
- La domandina -
🕵️♂️ Quale paese è il maggiore produttore di zafferano al mondo?
a) India
b) Iran
c) Pakistan
d) Italia
(Trovi la risposta in fondo alla newsletter)
⚡️ 3 ⚡️
- La curiosità della settimana -
Gravità extraterrestre: quanto peseremmo sugli altri corpi celesti?
La gravità è una forza fondamentale che dipende dalla massa e dalla dimensione di un corpo celeste. Se assegniamo un valore di 100% alla gravità terrestre e prendiamo un essere umano di massa pari a 70 kg come riferimento, vediamo come variano queste entità su alcuni corpi celesti più conosciuti.
1. Luna — 16,5% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 11,5 kg
La gravità lunare è solo un sesto di quella terrestre. Questo è il motivo per cui gli astronauti delle missioni Apollo sembravano rimbalzare quando camminavano sulla superficie lunare. Sulla Luna, un salto che sulla Terra ci farebbe sollevare pochi centimetri, ci proietterebbe in alto con facilità.
2. Marte — 37,6% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 26,3 kg
Su Marte, spesso presentato come pianeta colonizzabile, peseremmo circa un terzo del nostro peso sulla Terra. La debole gravità potrebbe portare a una perdita di massa muscolare e densità ossea per chi vi risiedesse a lungo, problematiche che stanno già studiando a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.
3. Giove — 253% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 177 kg
Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare e ha una massa che è circa 318 volte quella della Terra. La gravità di un corpo celeste è direttamente proporzionale alla sua massa, quindi Giove, con una massa così elevata, genera una forza gravitazionale molto intensa.
Così intensa che, anche solo per rimanere in piedi, si dovrebbe fare uno sforzo immenso. Tuttavia non potremmo mai davvero stazionare su Giove, poiché è un gigante gassoso senza una superficie solida. Qualunque cosa si “posasse” su Giove, affonderebbe nei suoi strati man mano più densi, attirata dalla gravità.
4. Saturno — 106% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 74,2 kg
Sebbene sia un gigante gassoso come Giove, la gravità di Saturno è simile a quella terrestre, a causa della sua bassa densità.
5. Plutone — 6,7% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 4,7 kg
Su Plutone peseremmo meno di 5 kg! Con una gravità così bassa, ad ogni passo prenderemmo il volo, come in un sogno a gravità ridotta. In più, la bassa gravità renderebbe difficile qualunque cosa si volesse lasciare ancorata al terreno.
6. Cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko — 0,0001% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 0,007 g
Se su Plutone vi doveste sentire ancora troppo appesantiti, qui pesereste solo pochi grammi! Sulla cometa 67P, resa famosa dalla missione Rosetta, la gravità è così debole che un piccolo salto potrebbe fornirci l’energia per mandarci in giro per lo spazio.
La missione Rosetta dell’ESA ha dimostrato quanto sia difficile lavorare su un corpo con gravità così bassa, dato che la sonda Philae, che doveva atterrare qui, ha rimbalzato sulla superficie a causa dell’insufficiente attrazione gravitazionale.
7. Sole — 2.740% della gravità terrestre
Peso dell’essere umano: 1.918 kg
Sulla superficie del Sole, se fosse possibile posarsi, un essere umano di 70 kg arriverebbe a pesare quasi 2 tonnellate! La gravità solare è così intensa che nemmeno la luce può sfuggire completamente alla sua influenza. Naturalmente, nessuna forma di vita come la conosciamo potrebbe mai avvicinarsi alla superficie del Sole a causa delle temperature estreme e dell’intensa radiazione. Ma rimane un divertente esercizio di immaginazione.
⚡️ 4 ⚡️
- Cultura generale in pillole -
L’origine della parola “Bohemien” e il suo legame con l’arte
In origine, “bohémien” era un termine francese genericamente riferito agli abitanti della Boemia, una regione storica dell’Europa centrale (oggi parte della Repubblica Ceca).
Nella Francia del XIX secolo si diffuse lo stereotipo secondo cui i gitani provenivano proprio dalla Boemia; per questo, “bohémien” iniziò a essere usato in senso esteso per descrivere persone che vivevano al di fuori delle norme sociali, lontane dai canoni borghesi, in condizioni di vagabondaggio e povertà.
A partire dal Romanticismo, “bohémien” iniziò a identificare artisti, scrittori e intellettuali che sceglievano uno stile di vita libero e anticonformista, rifiutando i limiti della società borghese e abbracciando uno stile di vita dedicato all’arte e alla creatività, anche a costo di vivere in ristrettezze economiche.
Henri Murger immortalò questo stile di vita nel suo libro “Scènes de la vie de bohème” (1849), che racconta le vite appassionate e travagliate degli artisti parigini. Questo lavoro ispirò altre opere famose, tra cui “La Bohème” di Puccini, e consacrò il “bohémien” come attributo dell’artista ribelle.
Oggi, l’aggettivo bohémien conserva parte di questo significato e indica una persona che adotta uno stile di vita o un’estetica libera e fuori dagli schemi.
⚡️ 5 ⚡️
- Cultura generale in pillole -
Perché non vediamo il nostro naso?
Facci caso: considerando il campo visivo di cui sono capaci gli occhi, dovremmo poter vedere il nostro naso, mentre di norma ci risulta invisibile!
In effetti, la nostra percezione visiva è molto più selettiva di quanto sembri.
Ogni secondo, gli occhi trasmettono una grande quantità di dati, ma se il cervello li elaborasse tutti, verremmo sovraccaricati di informazioni e non riusciremmo a concentrarci.
In nostro aiuto viene il meccanismo evolutivo dell’adattamento neuronale: i neuroni sensoriali rispondono meno a stimoli ripetitivi o statici e più a cambiamenti e movimenti improvvisi che potrebbero rivelare minacce.
Quindi il cervello usa una sorta di “filtro dell’attenzione” che elimina i dettagli che rimangono costanti o che non aggiungono nuove informazioni, come il naso, ma anche ombre o macchie fisse nel campo visivo.
Se invece proviamo a concentrarci intenzionalmente sul nostro naso, il cervello rende di nuovo visibile quest’area; appena smettiamo, torna a nasconderla, lasciandoci “liberi” di osservare l’ambiente circostante senza distrazioni.
Fine!
P.S. La risposta corretta della domandina è… 🥁🥁🥁
b) Iran
L'Iran produce circa il 90% dello zafferano mondiale, grazie alle condizioni climatiche favorevoli e a una tradizione secolare nella coltivazione di questa preziosa spezia. Per produrre un solo chilo di zafferano sono necessari oltre 150.000 fiori, raccolti rigorosamente a mano. Oltre all’Iran, anche Spagna, Italia e India sono produttori importanti, ma con volumi molto inferiori rispetto al mercato iraniano.