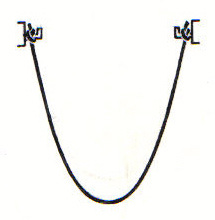La catenaria (e altre pillole di cultura generale)
Cultura Aumentata - Newsletter n° 64 - Tempo di lettura: 6 minuti
Menu del giorno: 💡 Un fatto strano ma vero / 🕵️♂️ La domandina / 📸 Viadotto di Garabit / 🔬 La catenaria / 📖 I beni Veblen
- Strano ma vero -
💡 I koala hanno un'impronta digitale quasi indistinguibile da quella umana, tanto che in teoria potrebbero contaminare una scena del crimine.
- La domandina -
🕵️♂️ Quale paese detiene il primato per il maggior consumo pro capite di caffè?
a) Brasile || b) Finlandia || c) Italia || d) Stati Uniti
(Trovi la risposta in fondo alla newsletter)
- Cultura visuale -
L’opera architettonica
Il viadotto di Garabit
Di che si tratta
Il ponte ferroviario di Garabit è un'opera ingegneristica affascinante di fine Ottocento. Si trova in Francia, nel dipartimento di Cantal, e attraversa il fiume Truyère. Fu progettato da uno degli ingegneri più famosi della storia, Gustave Eiffel (sì, lo stesso della Torre Eiffel di Parigi).
La costruzione è iniziata nel 1880 e si è conclusa nel 1884. L’arco principale misura 165 metri di larghezza e ha un’altezza di 122 metri sopra il fiume. La lunghezza totale del viadotto è di 565 metri.
Perché è emblematico
Questo viadotto è uno dei primi esempi di grandi infrastrutture in metallo e ha dimostrato le potenzialità del ferro come materiale strutturale.
È stato utilizzato principalmente il ferro battuto, con un peso totale di circa 3.600 tonnellate. Una scelta all'avanguardia per l'epoca, che anticipava l'uso di materiali simili in costruzioni di grande scala, come la Torre Eiffel.
Prima di aprire al traffico ferroviario, il viadotto venne sottoposto a prove di carico estreme, incluso il posizionamento di un treno carico di pietre su una parte dell'arco. Il collaudo dimostrò la capacità del ponte di sopportare carichi molto superiori a quelli attesi, grazie anche alla struttura ad arco catenario (ne parliamo nella sezione di cultura scientifica!).
Dal 1965 è classificato come monumento storico in Francia.



- Cultura scientifica -
Ingegneria
La catenaria
Esistono delle forme geometriche con proprietà e caratteristiche di elezione. Alcune sono ben note a tutti, come la circonferenza. Altre sono meno conosciute, anche se ne siamo letteralmente circondati. Tra queste vi è la cosiddetta catenaria.
Di che si tratta?
La curva catenaria è la forma assunta da un cavo (o una catena, o una fune, etc.) quando è fissato agli estremi e soggetto unicamente alla forza di gravità.
Quando un cavo è sospeso, ogni segmento è in uno stato di tensione uniforme, ogni punto del materiale è sottoposto allo stesso peso. La catenaria è l'unica forma che garantisce che la tensione sia distribuita uniformemente lungo tutta la lunghezza del materiale, senza momenti di flessione, il che la rende una struttura ottimale dal punto di vista statico.
Esempi comuni di catenarie
I cavi elettrici sospesi tra due tralicci: sono a forma di catenaria.
I ponti tibetani: le loro funi portanti si sviluppano a forma di catenaria.
Una collana appesa al collo e lasciata libera di posizionarsi: assume la forma di una catenaria.
Il calumo di un’imbarcazione: si estende dalla prua della barca all’ancora sul fondale seguendo il profilo di una catenaria.
Persino le ragnatele! Sono composte da tanti impercettibili segmenti di catenaria.
Curva catenaria e parabola NON sono la stessa cosa
La catenaria può essere confusa con la parabola, ma le due figure sono significativamente diverse. Per visualizzare la prima, ti basta osservare un cavo sospeso, mentre per la seconda devi immaginare la traiettoria di un proiettile sotto l'effetto della gravità e senza la resistenza dell'aria (e poi capovolgere la figura).
Entrambe le figure sono “disegnate” dalla forza di gravità, ma la catenaria è modellata anche dalle forze dovute ai due vincoli alle estremità. Come risultato delle forze in gioco, la catenaria ha un punto di sospensione più piatto rispetto alla parabola.
Il parametro a e l’ampiezza della catenaria
Matematicamente, possiamo rappresentare la catenaria come:
dove cosh è il coseno iperbolico, una funzione che definisce il comportamento principale della curva, mentre a è il parametro che rappresenta l’apertura della curva: più alto è il valore di a, più la curva avrà una forma “aperta”.
La catenaria invertita
Per la sua eleganza matematica, la catenaria ha avuto particolare successo nella progettazione di strutture complesse: ponti, archi, cupole.
L’arco catenario è la struttura architettonica che si ottiene ribaltando la forma della catenaria: il punto inferiore diventa il più alto, e viceversa i punti di ancoraggio diventano quelli posizionati più in basso.
A differenza degli archi tradizionali, come l'arco romano (a tutto sesto) o l'arco gotico (a sesto acuto), l'arco catenario non richiede l'uso di contrafforti o altri elementi di supporto, dato che la sua forma consente una distribuzione omogenea del carico e delle pressioni interne lungo l'intera struttura, rendendo l'arco intrinsecamente stabile ed equilibrato: ogni parte dell'arco contribuisce egualmente a sostenere il carico, eliminando punti di tensione concentrata che potrebbero portare a cedimenti strutturali.
Esempi noti di catenarie in architettura
Antoni Gaudí, il famoso architetto spagnolo, utilizzava modelli di catenaria rovesciata per progettare le sue strutture uniche, tra cui la Sagrada Familia a Barcellona. Gaudí appendeva catene reali a un soffitto e le osservava al contrario attraverso uno specchio per visualizzare la catenaria invertita e trasferire quella forma nelle sue strutture.
Il viadotto di Garabit, in Francia, è uno spettacolare ponte ferroviario in ferro, progettato da Gustave Eiffel e completato nel 1884. L’arcata principale è sostenuta da una catenaria invertita.
- Cultura umanistica -
Economia
I beni Veblen
I beni Veblen prendono il nome dall'economista Thorstein Veblen, che li introdusse nel suo saggio "Teoria della classe agiata", del 1899.
Questi beni hanno una caratteristica particolare: la loro domanda aumenta al crescere del loro prezzo, il che contraddice le leggi tradizionali della domanda e dell'offerta.
Come funziona la dinamica dei beni Veblen
Normalmente, il rincaro di un bene ne scoraggia la domanda da parte dei consumatori. Nei beni Veblen invece, l'aumento del prezzo può rendere tali beni più desiderabili, perché vengono percepiti come simboli di status sociale ed esclusività.
Un esempio pratico
Prendi un orologio di lusso da 20.000 €. Non si tratta solo di un oggetto per guardare l’ora: è anche e soprattutto un simbolo di ricchezza e status. Se il prezzo dello stesso modello dovesse aumentare fino a 100.000 €, potrebbe diventare ancora più desiderabile, poiché sarebbe ancora meno alla portata del pubblico: il suo acquisto rappresenterebbe un simbolo ancora più marcato di capacità finanziaria. Quando l’oggetto diventa effettivamente più acquistato, in seguito al suo aumento di prezzo, ci troviamo davanti a un bene Veblen.
Altri esempi tipici includono: borse griffate, auto di lusso, opere d’arte e gioielli di alta gioielleria. In tutti questi casi, i prezzi proibitivi aggiungono valore percepito ed anzi, il prezzo elevato diventa una caratteristica che induce all’acquisto più delle effettive peculiarità dell’oggetto.
Origine della teoria
Thorstein Veblen elaborò questa teoria nel contesto delle sue osservazioni sulla classe agiata dell'America di fine Ottocento. Egli notò che alcuni membri della società spendevano grandi somme di denaro per beni che fungevano da indicatori visibili della loro ricchezza, più che per il reale bisogno degli oggetti stessi. Questo comportamento è noto come “consumo ostentativo”, che è fondamentale per comprendere i beni Veblen: si acquistano beni per mostrare il proprio status piuttosto che per soddisfare una necessità pratica.
P.S. La risposta della domandina è:
b) Finlandia ☕️